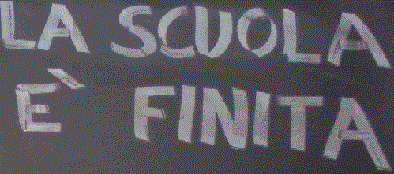Ancora una lettura dal compianto Alcofribas, caro agli dei (il passo goliardico
sì spinto era forse un segno che non ce la faceva più: come non comprenderlo?)
ERNESTO SPARAVVISTA DAL BALCONE
L’ITALIA, OGGI COME OGGI (IL VIRUS
COMUNISTA)
Acapìto Editore, Pag 111 Euro 12,50
Il lavoro dello storico, si sa, conosce
un momento di crisi.
La legittimazione che gli veniva dal
rispetto dei protocolli procedurali, dalla serietà della ricerca sulle fonti
oggi è considerata un fardello inutile, un’esibizione di pedanteria che non
giova alla causa. Parla come magni innanzitutto, fatte capì, possibilmente
damme ragione che è meglio. Ma prima ancora: di’ cazzate ma dille a mo’ de’
romanzo, dille nervoso, o superbo, o ironico, dille come cazzo te pare ma dille
in televisione e fatte intervista’ da giornalisti accomodanti (da giornalisti
italiani, diciamo). Questi i nuovi paradigmi del mestiere.
Oggi pertanto gli storici che vanno per
la maggiore non sono storici propriamente detti e va bene così. Si chiamano
Giampaolo detto Panza (perché lavora de panza e non con la capoccia che poi te
vie’ er mal de testa), un certo Bruno detto Vespa per via dei comedoni in faccia porello e perché hai voglia de sbattelo
cor canevaccio, te lo ritrovi minimo ogni anno a Natale (difatti essendo fuori
stagione è chiaro che l’individuo è fatto un po’ a cazzo, entomologicamente
parlando; si sospetta che sia stato geneticamente modificato a Palazzo Chigi),
oppure Dajefoco Pierangelo (o Pierannununzio, perdonate l’amnesia).
Su questa scia sembra proseguire il
lavoro di uno che invece storico di professione ci sarebbe. Parliamo di Ernesto
Sparavvista Dalbalcone. Ne L’Italia, oggi come oggi (il virus comunista), ha messo insieme i suoi articoli pubblicati negli
ultimi anni sul Corsega e ne ha fatto un libello assai chiaro nelle intenzioni
e nella linea conduttrice. Va detto che non è un’antologia di testi vaganti
pretestuosamente messi insieme per farne un bel volumetto elegante da esibire
in libreria. C’è un filo abbiamo detto, una ragione unitaria che lo giustifica.
Esso sta nell’individuazione definitiva del male indigeno, nella scoperta della
causa prima e ultima dei nostri guai. Sparavvista Dalbalcone non la manda a
dire: il problema in Italia si chiama Comunismo. Proprio così. ‘Sto cazzo de’
comunismo non ne vole sape’ de togliese dalle palle. E’ morto in tutto il mondo,
da noi niente da fa’. Che tu leggi e pensi: ma sei sicuro? Pensi, ma questo
dove li vede tutti ‘sti comunisti? Pensi: roba che a me certe volte mi viene un
po’ de nostalgia, mica proprio del comunismo, no, ma della giovinezza. La
solita storia no? Che te ricordi de quando eri giovane. E pensi: oh, se ne
incontrassi uno, magari cominci a dire Oh, te ricordi? Te ricordi i festival
dell’Unità, la puzza delle salsicce alla brace che saliva dentro casa? E poi
non è mica vero che erano tutte cozze, ‘ste compagne. Ci avevi rimediato pure
qualcosa, un paio de volte.
Insomma, leggendo nn momento di
difficoltà arriva. Ma Sparavvista Dalbalcone va dritto per la sua strada. Dice
guarda che i comunisti si nascondono, se ‘nguatteno, dicono e non dicono, e
questa mentalità, la mentalità dei comunisti è più diffusa di quello che pensi.
E’ una mentalità che ci lascia indietro, come paese. E’ una cosa così infetta
che nonostante il cumenda abbia
tutto in mano, comprese le televisioni di questi nuovi storici, l’Italia ancora
arranca. Il virus comunista è ancora in giro a fare danni. Punto.
E una volta tanto il recensore un po’
sospettoso, si mette sul piano del semplice, ingenuo lettore. Il recensore
pensa: perché debbo vedere sempre il sottotesto, le sottotracce, il
sottosemaforo? Perché non farsi trascinare una volta dalla lettura senza il
sopracciglio alzato del critico prevenuto? E pensa: se Sparavvista Dalbalcone
gli dà dentro con tanta passione un motivo ci sarà. Lui vede cose che io non
vedo. E’ uno storico o non è uno storico? E’ pure aggiornato!
Così lo segue sino in fondo, questo
storico coi controfiocchi, forse un po’ fissato, un po’ autistico, ma lo segue
fino all’ultimo capitolo, intitolato “Dopo la diagnosi, la terapia”. Qui il
lettore mi scuserà, ma per ragioni di spazio il recensore sarà sintetico. Be’,
nell’ultimo capitolo si dice a chiare lettere: “Comunisti, non è ora di alzare
i tacchi? (sic). Comunisti che vi annidate nei gangli” (dice proprio nei
gangli) “fate un favore a chi ci governa e fatelo lavorare, lui e gli italiani
come lui: sparatevi, fatevi fuori, sopprimetevi”. Che il recensore sottoscritto
un po’ si dispiace. Anche perché se ‘sto comunismo è come la nebbia che c’è ma
non si vede, non vorrei che poi uno s’insospettisce di tutto e spara pure alla
moglie insegnante che si lamenta del basso stipendio. Potrebbe pure pensare che
è una manovra della disinformazione comunista. Che hai un terrorista dentro
casa, addirittura. E’ un libro da meditare, lettori.
Alcofribas